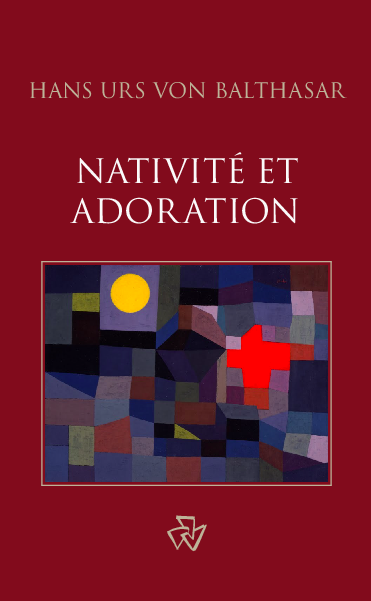menu
Sulla preghiera continua
Nel Nuovo Testamento l’invito alla preghiera continua è pressante e continuamente ripetuto con svariate espressioni. Paolo invita la comunità a pregare «senza intermissione» (a-dialeiptōs (1 Ts 5,17); a vivere «pregando incessantemente (en panti kairōi) con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi e anche per me» (Ef 6,1.8 e ss.). Più volte egli adopera un termine che significa «trattenersi costantemente, stabilmente presso qualcosa, rimanere vicino»: «Perseverate (pros-kartereite) nell’orazione» (Col 4,2); «Siate perseveranti (proskarterountes) nella preghiera» (Rm 12,12). Paolo stesso prega «giorno e notte, con viva insistenza (hyper-ek-perissou)» per i suoi, per completare ciò che ancora manca alla loro fede (1 Ts 3,10), «prega di continuo (pantote) per loro» (2 Ts 1,11), affinché la loro disposizione al bene si compia (cfr. inoltre Rm 1,10; 1 Cor 1,4; Ef 5,20; Fil 1,4; 1 Ts 1,3; 2,13; Fil 4; ecc.). In questo egli è solo l’eco di Gesù, che narra la parabola della supplica della vedova dinanzi al giudice iniquo «per far vedere che bisogna sempre (pantote) pregare senza stancarsi» (Lc 18,1). Mentre in Luca noi vediamo Gesù che prega nei grandi momenti della sua vita (battesimo, chiamata dei discepoli, trasfigurazione, monte degli ulivi, croce) Giovanni ce lo mostra in un continuo colloquio di preghiera con il Padre: «continuamente», egli guarda al Padre, per fare ciò che il Padre fa e gli manifesta nell’amore (5,19ss.); «continuamente» fa ciò che piace al Padre (8,29); sa che il Padre lo esaudisce «sempre» (11,42), il che presuppone che una continua preghiera suoni anche dal Figlio al Padre. Nemmeno la croce interromperà questo colloquio (cfr. 16,32). La tradizione non poteva trascurare questo esempio e questi inviti, essa sin dall’inizio li ha afferrati e ha cercato continuamente di spiegarli in modi sempre nuovi. E ogni epoca deve farsi ripetere il comando e riflettere un’altra volta sulle sue conseguenze.
1. Il mondo immerso, circondato e vivificato dal Verbo
Le parole di Gesù «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno» (Mt 24,35) manifestano la sua coscienza di abbracciare e vivificare (umleben, come dice Guardini) tutto ciò che è sottomesso al tempo e alla transitorietà. Ciò non significa soltanto che il mondo è immerso in questa vita come in un manto protettore, ma anche che esso ne è compenetrato, ne è trascinato dall’interno come dal suo principio. Se d’altronde il detto sembra riferirsi anzitutto alle parole pronunciate da Gesù, e sicuramente di fatto vi si riferisce, tuttavia queste sue parole sono tanto espressione del suo essere, del suo fare e pensare, tanto discorso incarnato, che questo principio è Gesù stesso nella sua indissolubile totalità. Entrambi gli aspetti ci conducono alla cristologia giovannea: da un lato il mondo, come totalità è creato nel Verbo che era «in principio», dall’altro questo Verbo-principio, nella sua esistenza terrena, nella vita, nella morte e risurrezione di Gesù, è l’incarnato che è immanente fin nell’intimo alla natura del mondo e alla storia.
L’insegnamento del prologo di Giovanni non nasce dal nulla, è la fioritura di un bocciolo ancor chiuso nei presagi pre-biblici, e che già si apriva nell’Antico Testamento. Per gli antichi popoli dell’Egitto e del vicino fino all’estremo oriente, il mondo visibile è allo stesso tempo manifestazione di un pensiero, o suono, o parola, che è ad esso immanente e che insieme ad esso sgorga dalle imperscrutabili profondità originarie. Nella loro radice ultima queste espressioni hanno un significato equivalente, come dimostra la radice indoeuropea bhă, che si interpreta sia come sorgere luminoso, apparire (greco «phaō», epifania, phaos = luce; sanscrito bha-tis: splendore) sia come dichiarazione (latino fateor: palesare; fas: la parola divina; fatum: ciò che è «detto» all’uomo dalla divinità). Per Eraclito il Logos eterno risuona attraverso il rumore guerresco delle cose, e similmente per Lao-Tse, e per i pitagorici questo ordine razionale diventa udibile nell’armonia delle sfere; sempre i poeti hanno tentato di udire il canto che dorme in tutte le cose (Eichendorff), e (secondo A. v. Thimus Harmonikale Symbolik des Altertums, 1868-1869) Hans Kayser ha dedicato l’opera della propria vita (Akroasis, die Lehre von der Harmonik der Welt, 1947) all’ascolto di questo «canto». Che cosa vogliono «dire» le cose? Si può tendere l’orecchio, al di là delle lingue articolate, «categoriali», alla lingua originaria (Ursprache) del mondo nel suo fondo trascendentale? Certo non per mezzo di semplici astrazioni formalizzanti, come tenta di fare l’odierna logica del linguaggio, allontanandosi dalla realtà delle cose, ma piuttosto – come traducono le fiabe nella loro ingenuità – per mezzo di un nuovo udito che porga l’orecchio non solo al linguaggio degli alberi e degli animali, ma anche a quello delle piante e delle pietre, della luce e della notte.
La soglia dal pre-biblico al biblico viene varcata nel meraviglioso Sal 19, che inizia immettendo nella rivelazione la concezione assiro-babilonese di una silenziosa scrittura celeste, annotata nelle stelle e decifrabile dal saggio:
I cieli narrano la gloria di Dio
e l’opera delle sue mani proclama il firmamento
il giorno racconta al giorno il messaggio
e la notte rivela alla notte la conoscenza.
Non è linguaggio, non son parole
di cui sì possa ridire la voce.
Il loro suono si spande per tutta quanta la terra
e i loro accenti sino al confine del mondo
La successiva epifania del sole fa pensare agli Egiziani, ma improvvisamente, senza trapassi, ecco al posto del sole lo splendore della Torah di Jahwe, «pura», «limpida», «vera», che «illumina gli occhi». La misteriosa lingua originaria (di cui ancora Herder era entusiasta) diventa qui chiaramente comprensibile, e non si può dire, come la Torah qui si rappresenta, se essa sia lingua articolata (categoriale) o trascendentale del mondo. Le speculazioni degli Ebrei sulla Torah l’hanno sempre più avvicinata al principio basilare del mondo; in seguito essa coincide con la sapienza, creata all’inizio del disegno di Dio (Prv 8,22), «con» la quale Dio ha fondato la terra e il cielo (Prv 3,19). Luce-suono-lingua: in questo modo siamo già sulla soglia del prologo di Giovanni, infatti il Logos, la luce degli uomini (1,4), è anche colui che ci ha «rivelato, nel modo di una lingua, il Dio mai veduto» (1,18).
Il «Verbo» di Giovanni ci viene però rappresentato sotto un duplice aspetto in modo più chiaro di quello dell’Antico Testamento. Certo, già la sapienza è «la delizia di Dio ogni giorno, dilettandomi dinanzi a Lui in ogni istante» ed essa stessa pone le sue delizie «tra i figli dell’uomo» (Prv 8,30/31); certo essa «siede accanto (paredros) al trono» di Dio e nello stesso tempo è la sua parola, per mezzo di cui Dio ha creato il mondo (Sap 9,4; 9,1). Ma ormai il Verbo è «nel seno del Padre» (esattamente «volto al suo seno» Gv 1,18) è «in principio presso Dio» (1,2). Non come primo, già procedendo da Dio, quale principio del suo creare, bensì linguaggio, espressione del rivolgersi e del ritorno al Padre, luce, suono, e qui anzitutto Verbo, in un colloquio eterno che Giovanni mostrerà sempre più profondamente come il colloquio originario, dell’amore. Non distolto verso il mondo, bensì autosufficiente nella reciproca conoscenza tra Dio e il suo Verbo, e, quindi, in questa libera e perenne autosufficienza, principio del mondo. In quanto luce-suono-colloquio, già rivelazione, ma così libera da dover ancora una volta manifestare sé stessa per poter essere capita. Nulla a questo proposito si esprime più chiaramente che l’aerolito di Giovanni nei due grandi sinottici: «nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo» (Mt 11,27; cfr. Lc 10,22).
Così il geroglifico del mondo, che tutta la sapienza umana cerca di decifrare, nel Nuovo Testamento diventa più chiaro, più profondamente rivelatore – e nello stesso tempo più nascosto – poiché per essere spiegato dipende dalla libertà del Figlio. Usiamo per l’ultima volta questa ingannevole coppia di concetti, per poi abbandonarla definitivamente, in quanto ci può sviare, e diciamo: poiché il Verbo diventa carne, la lingua trascendentale viene resa categorialmente univoca e in questo modo viene liberata dall’arcano di una scrittura segreta e apparentemente limitata. Ma, poiché il Verbo diventa carne, e proprio in questo modo (soffrendo, morendo) annuncia l’amore del Padre, il senso trascendentale del colloquio divino originario si manifesta in questo categoriale – nella categoria dell’intera esistenza umana – così che l’esistenza non potrà mai più essere astratta da questa lingua. Ma come l’incarnazione del Verbo di Dio è avvenuta liberamente, così anche il Figlio resta libero di manifestare a chi vuole il dialogo tra sé e il Padre: «Ti lodo, o Padre, poiché hai nascosto queste cose ai saggi e ai sapienti», agli astrologhi, agli psicologi e ai tecnici della mistica, «e le hai rivelate ai piccoli». Vedremo poi perché. E mentre concede liberamente l’accesso, concede anche la libertà dell’accesso: la fede che non viene mai pretesa da Dio, che può essere soltanto liberamente donata a Dio, e che proprio in questo libero abbandono dell’uomo alla libertà del Verbo compie il senso della sua incarnazione: iniziare l’uomo alla luce-suono-parola della lingua originaria (Ursprache) – l’amore di Dio –: la parola (Wort) vuole risposta (Ant-Wort) la lingua (Sprache) vuole corresponsione (Ent-sprechen), affinché il dialogo nei cieli divenga ormai anche un dialogo tra cielo e terra.
Per quanto qui il concetto di dialogo debba essere messo tra parentesi. Infatti il Verbo, che abbraccia e vivifica il mondo, procede sì dal seno di Dio e a questo seno ritorna, ma in esso «il Verbo stesso, è Dio» (Gv 1,1). Ma l’incontro di Dio con Dio è al di là del dialogo tra due esseri. Bisognerà dunque dire che finché Dio, che si manifesta liberamente agli uomini, incontra come l’essere semplicemente Altro, il «Verbo in principio» non è stato ancora assegnato loro definitivamente.
2. Dio l’Altro e l’Uno
Dal momento in cui la scrittura runica del mondo cede dinanzi alla libera rivelazione di Dio agli uomini, in cui Dio chiama Abramo, in cui dal roveto annuncia a Mosè il proprio nome e la sua missione, in cui dal Sinai, sceglie il popolo e gli impartisce i suoi ordini, Egli è anzitutto l’Altro dominatore. Il pensiero e il concetto dell’alleanza vi corrisponde; esso presuppone due libertà che si incontrano, anche se l’una procede sovranamente prendendo l’iniziativa, e nel far ciò ritiene l’altra degna di associarsi. L’esperienza della libertà e della parola di Dio è necessaria all’uomo, poiché senza di essa si spegne ogni conoscenza vivente del Logos che tutto abbraccia. Essa si oscura o in speculazione sopra il senso che, sempre inspiegabile, sfugge (l’Uno di Plotino al di là della ragione è inconoscibile, ormai solo oggetto di una eludente nostalgia) oppure in una forma di magia – come gnosi o astrologia, o come un’etica che sa maneggiare la legge del mondo – attraverso cui l’uomo si impossessa della legge dell’universo che lo circonda, la decifra, la vive, e quindi, senza accorgersene, la trasforma nella sua legge e nel suo essere. Egli si proietta nel cosmo, diventa misura di tutte le cose. Nella svolta decisiva dall’uomo che ascolta all’uomo che fa, dall’homo contemplans all’homo faber, il Verbo che abbraccia vivificando il mondo, necessariamente tace. L’uomo manipola il materiale plasmabile dell’universo. La natura parla del divino, la tecnica e la cultura parlano all’uomo soltanto dell’uomo. La malattia, l’ingiustizia, la morte lo sollecitano a riflettere sul modo per metter fine al disordine. Egli diviene signore delle cose, che – in quanto evoluzione – sono le sue fondamenta, a cui egli non ha bisogno di sentirsi debitore di sé, poiché sta loro sopra, e può usarne gli stadi preliminari come cava per la propria azione «umanizzatrice» di cambiamento del mondo. «Tramonta bel sole, essi ti hanno prestato poca attenzione, essi non ti hanno conosciuto, o santo»; gli dei di Hölderlin non possono essere riportati indietro. Nulla incontra più qualcosa se non l’uomo sé stesso, i rumori di fondo della radio che sempre rumoreggia – quando si cucina, quando si legge, persino quando si parla – hanno infranto a terra la musica delle sfere: al posto del suono un rumore, al posto dell’ascolto una quinta sonora. Dove si potrebbe udire un rumor of Angels, il potere cerca di afferrare le «forze occulte» per metterle al servizio della politica1.
Eppure questa liberazione dell’uomo, che tende alla conquista di ciò che lo circonda, nella storia del mondo ha avuto origine quando Dio si è manifestato come l’Altro libero e si è così rivolto all’uomo nella sua libertà: cioè nello spazio biblico. E per rivelarsi come questa libertà, per abolire ogni sospetto di una autoproiezione dell’uomo sulla parete del cosmo, egli ha sempre drasticamente condotto l’uomo – il singolo come il popolo – «dove tu non vuoi» (Gv 21,18). È così avvenuto che la sua libertà fosse sentita come tirannide, la sua legge come alienazione, la sua alleanza come legame molesto e Paolo ritenne giustamente: «Io un tempo vivevo senza la legge. Ma, sopraggiunto quel comandamento, il peccato ha preso vita e io sono morto; la legge, che doveva servire per la vita, è divenuta per me motivo di morte» (Rm 7,9/10). Lo stadio in cui Dio si fa avanti come il libero Altro, può essere soltanto una fase di passaggio, che assolutizzata non può che condurre a malintesi e sviluppi errati: la legge par-eisēlthen è «sopraggiunta» (Rm 5,20), in cui il para allude a un uscire di strada.
Soltanto il radicalismo, così come Paolo lo usa nella lettera ai Galati, può condurre fuori – in avanti! – da questa tragedia epocale, che incominciò al Sinai e nel cui quinto atto la moderna cultura tecnica vive o piuttosto muore. Il Dio, che si è rivelato al popolo come l’Altro libero, era dapprima apparso ad Abramo come Colui che promette, ponendo così le basi per tutto ciò che doveva seguire. Esaltante – come le stelle in cielo e la sabbia del mare, la benedizione per tutti i popoli – è per la dedizione di fede lo sguardo su Dio. E tuttavia questa promessa non si dissolve nel quantitativo; «ora le promesse furono fatte ad Abramo e al suo “discendente”»; non dice mai «discendenti» come se si trattasse di molti, ma di uno solo «e al tuo discendente», che è Cristo (Gal 3,16). Mosè, dimostra in seguito Paolo, era un mediatore tra due, l’Uno, Israele, e l’Altro, Dio. Ma ciò era solo «pedagogia» (Gal 3,24), esercitazione nella libertà di Dio, che voleva tutt’altra cosa che essere il nostro Altro. Come dunque è possibile ciò senza cadere nel panteismo o nell’ateismo? Solo con tremore si può seguire il pensiero di Paolo, tanto è delicato e suscettibile di essere frainteso. La promessa di Dio è Cristo, o «Dio con noi», «Dio invece è uno solo» (Gal 3,20). Poiché, «il tutto è Lui» (Sir 43,27), perciò l’«alleanza eterna e definitiva» sarà annullamento di ogni alterità nell’unità di Cristo, che è Verbo di Dio e Dio: «non c’è più giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio, né femmina, perché tutti siete uno solo in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Quindi noi siamo attratti dentro l’assoluta, avvolgente libertà di Dio, che in eterno amore custodisce nel suo seno suo Figlio, il suo Verbo, in sé lo emette e di nuovo abbraccia ciò che a Lui ritorna. Questo Figlio, il Verbo incarnato, è l’alleanza compiuta, l’incontro personale tra Dio e l’uomo che recupera il confronto tra estranei in una intimità interna a Dio che non può essere espressa categorialmente. «Quindi non sei più schiavo, ma figlio; se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio» (Gal 4,7).
Due fatti dunque avvengono contemporaneamente: «quando venne la pienezza del tempo» in cui dovette realizzarsi l’immensa promessa degli inizi, «Dio mandò il suo Figlio», il Verbo che dà vita al mondo, «nato da donna, nato sotto la Legge» (Gal 4,4); lo mandò nella condizione dell’esistere umano sotto la volontà di Dio libero, più concretamente ancora: nella condizione dell’uomo che si allontana da Lui; nulla di questa condizione dovrà restare estraneo al Figlio, egli dovrà berne fino in fondo il calice con la sua essenza di Verbo, dovrà tutto trasformarlo in una risposta di amichevole obbedienza: Verbo come risposta, e risposta come Verbo. E di conseguenza il secondo fatto: ciò che di altro, di estraneo esiste tra Dio e l’uomo, Egli dovrà trasformarlo in un «Verbo presso Dio»: la durezza del quotidiano, e il fallimento e la morte: tutto trasformare nel Verbo di Dio che è la luce e la vita dell’uomo. Ciò ci pone di fronte al tremendo paradosso che l’uomo (ora figlio, non più servo) è tanto più libero quanto più vive nella libertà assoluta, cioè divina. Il fatto che Dio sembrava essere l’Altro contrapposto era solo una fugace apparenza, che ora è superata nella verità: escatologicamente Dio è «il tutto in tutte le cose» (1 Cor 15,28) e questo tempo finale è iniziato con la morte e la resurrezione del Figlio. Per questo la chiesa non è la «compagna» di Dio o di Gesù, bensì la sua pienezza e il suo corpo; la sua «sposa» ma solo in quanto essi formano «una sola carne» (Ef 5,31ss.) oppure «un solo spirito» (1 Cor 6,17).
L’unico Spirito è ciò che agisce come «Noi» tra Dio Padre e il suo Verbo; mentre questo Spirito, il Verbo di Dio pronunciato ed effuso fino alla morte viene per noi donato, il patto bilaterale dell’Antico Testamento è superato: lo Spirito, che il Figlio ci dà da «bere» scorre così da noi stessi come una sorgente (Gv 4,14; 7,38). La Legge è (sovra) compiuta, ciò che chiediamo ci viene donato «anticipatamente» (Ef 2,10), affinché noi lo compiamo a partire dal dono. La nostra azione non diviene per questo superflua, piuttosto essa è segno che la sovrabbondanza della grazia divina ha veramente raggiunto il suo fine. Per questo la vita e l’azione cristiana, conformi a Dio, sono un’«accelerazione» della fine, della parusia.
Poiché il Verbo si è fatto carne, tutto ciò non è vuota speculazione dialettica. Nella vita di Cristo si tratta piuttosto di rendere presente vivendolo, nella semplicità e nella lotta dell’umana quotidianità, il divino rivolgersi del Verbo dal Padre e al Padre: ciò che Gesù proclama nelle beatitudini (Lc 6,21ss.) lo vive in primo luogo egli stesso: la trasparenza dell’essere-soltanto-Verbo-del-Padre (nella povertà, nella fame, nel dolore, nell’impotenza, nella spoliazione) dell’essere semplicemente trasmissione (Gv 7,16; 14,10.24) nel puro rivolgersi al Padre. La trasparenza divina «si è fatta carne». Mai si è parlato in modo umanamente più chiaro, più schietto, più efficace, più commovente. Il canto che dorme in tutte le cose viene svegliato nel discorso a partire dalle cose della natura e della vita dell’uomo (della vita dei contadini e dei pastori, della conoscenza del grano e dei fiori e della vite, del cucinare e del comprare, della zizzania e del furto, del guadagno e dei processi, della punizione e della ricompensa, e così via) e tutto ciò diventa espressione dell’interno sentire e della vita di Dio. Ciò che è più chiaro rimane inesorabilmente segreto, non perché i geroglifici del mondo siano pure «cifre», ma perché il segreto del profondo è emerso fino alla superficie della quotidianità umana. Ma, in questa autoesposizione, la profondità e il segreto non vanno perduti, per cui il vedere e l’udire esigono la fede, l’apertura del cuore a Dio, attraverso Dio. Non è che da ciò che si conosce si possa desumere quanto in esso si annuncia, giacché bisogna già intendere lo stesso dato conosciuto – il crescere del seme, il lievito nella farina – come la lingua del mistero.
Ciò diviene totalmente chiaro là dove l’azione di Gesti diventa miracolo, e ancor più chiaro là dove il soffrire e il morire umano diventa lingua dell’amore divino che in esso vince. Qui non si può mai presupporre di aver capito l’«essenziale». Si tratta della lingua nascosta e sconosciuta dell’amore assoluto, che qui si fa conoscere attraverso tutti i fallimenti umani. Nulla per Dio è così altro che Egli non possa essere in esso l’Uno.
3. Sapere udire
«Dio è spirito» (Gv 4,24), tutto in Lui è vita cosciente, non si può avere in sé la vita divina soltanto «sostanzialmente» come puro «stato di grazia» oggettivo. Bisogna plasmare in sé i sensi per l’intenzione divina, per la fede vivente che Dio esige da tutti coloro in cui vuole operare la Sua salvezza. «Chi ha orecchie per intendere intenda!» Intendere nel suo primo, basilare stadio: come udire, tendere l’orecchio. Si può descriverlo come una disposizione attiva a cogliere ciò che da sé risuonerà, e in modo tale da comprendere e compiere ciò che «vuol dire». Bisogna ancora fare un passo avanti. Per ascoltare veramente, io devo mantenermi aperto di fronte a tutto quanto potrebbe richiedermi «ciò che risuona», in modo da sentirlo veramente così come esso suona.
Se ciò che giunge è il Verbo di Dio, la disposizione all’accoglienza deve essere totalmente sconfinata nei suoi confronti. Dio, e soltanto Dio, ha il diritto di poter pretendere tutto dall’uomo, poiché la sua parola è salvezza, e chiede solo per donare meglio. E per ricevere la salvezza di Dio l’uomo deve radicalmente rinunciare a tutto e togliere da sé tutto quanto in lui toglie spazio a Dio. I «poveri di spirito» sono coloro che si sono svuotati, spogliati, denudati, per essere ospitalmente pronti per il Verbo che giunge. A questo proposito Gesù pone, come esempio, il bambino tra i discepoli. Il bambino è aperto a tutto ciò che gli giunge, non ha ancora idee preconcette, non principi, non assiomi, non «ha l’abitudine di dire», non conosce la saccenteria, non è fissato su nulla. La sua naturale povertà gli dà la ricchezza della propria disponibilità a prendere tutto come gli si offre. «Parla, Signore, il tuo servo ascolta», dice il fanciullo Samuele.
Qui diventa improvvisamente chiaro come tutto ciò, che nella disponibilità richiesta sa di tecnica, vada contro l’evangelica «grazia dei piccoli». Chi adopera e usa delle tecniche per giungere alla «concentrazione», al «raccoglimento», al «distacco», al «ritrovamento dell’io» per allargare il proprio spazio interiore – attraverso la «meditazione trascendentale», lo yoga, lo zen o quali altri esercizi esistono – non è povero in spirito. È piuttosto pieno di conoscenza e di potere, appartiene ai ricchi che non passano per la cruna di un ago, ai «saggi» e ai «sapienti» a cui il Padre ha celato le sue cose. Egli è, in fondo, un fariseo, che confida nelle proprie opere invece di affidarsi con fede a Dio; infatti tecnica significa realizzazione, anche quando ha per fine l’«afferrare» la povertà interiore. Proprio perché non ha di fronte nulla che si manifesti attivamente da sé, colui che medita secondo i metodi orientali deve raggiungere la propria passività per mezzo del proprio sforzo. Al contrario, ciò che si rivela opera anticipatamente, nel cristiano che medita, una verità che non gli è estranea, bensì sua propria, e che egli deve soltanto riconoscere. Il fatto che Maria sia la serva del Signore, nella quale egli può agire secondo la propria volontà, è espressione della sua «povertà», della sua «piccolezza», della sua «umiltà» (Demut, cioè Dien-Mut, da dienen: servire), e non di una altezza spirituale da lei stessa raggiunta; Maria lo sa: Egli abbatte i potenti dai troni.
Questo atteggiamento non è affatto tenuto in serbo solo per il momento della preghiera; è l’atteggiamento costante del cristiano. Il cristiano rinuncia alla presunzione tanto nei confronti di Dio quanto nei confronti del prossimo. Come dalla parola di Dio, così egli si lascia dire qualcosa e, se necessario, si lascia provocare anche dalla parola del prossimo; può «lasciar fare» cose che agli altri paiono impossibili. «Lascia fare», dice Gesù al Battista, quando questi si spaventa all’idea di battezzarlo. Il cristiano estende alla vita di tutti i giorni il rendimento di grazie e l’Eucaristia, in cui vive di fronte a Dio: «insultati, benediciamo» (1 Cor 4,12). Ignazio martire fa eco: «Anche per gli altri pregate senza interruzione, poiché c’è speranza del loro ritorno… Alle loro ingiurie opponete preghiere» (Ef 10,1). Secondo tutti i maestri di spiritualità la disponibilità attiva nei confronti di Dio esige «assenza di passioni» (Antichità), «tranquillità» (Medioevo), «indifferenza» (Rinascimento, ma già Agostino), distacco dalle inclinazioni disordinate, che potrebbero creare un a priori negativo per la nostra risposta a Dio: l’atteggiamento resta invariato attraverso la preghiera e la vita quotidiana. Tra la preghiera in atteggiamento di ascolto e il porgere l’orecchio alla quotidianità esiste un’osmosi continua, così che l’ascolto in un campo permette e favorisce l’ascolto nell’altro, e ciò in modo essenzialmente reciproco.
Chi impara a tendere l’orecchio a Dio impara nello stesso tempo ad ascoltare le cose che quotidianamente lo incontrano in un continuo cambiamento. Esse non possono parlar d’altro che di Dio. Torniamo, a un livello più puro, alla capacità degli antichi di udire la musica delle sfere, di oscillare nell’equilibrio del Tao, di «trovare Dio in tutte le cose». D’ora in poi è profondamente indifferente avere di fronte natura o cultura, uomini aperti o chiusi, che ci vengono incontro o che ci voltano le spalle. La frase di Gesù «ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a me» può essere ampliata senza esitazione, così da suonare «ciò che in una circostanza ricevete da un qualsiasi uomo lo ricevete da me». E fossero pure gli schiaffi e i colpi di flagello che Cristo stesso ha accolto come volontà del Padre. Dal momento della croce Dio è trasparente nella luce come nelle tenebre del mondo, purché noi sappiamo ricevere entrambe con cuore disarmato. Se si è riconosciuto e sperimentato nella realizzazione orante della fede che tutto è grazia, la parola «dovere» dovrebbe sparire dal vocabolario del cristiano, per essere sostituita dalla parola «potere», «avere il diritto». Noi possiamo seguire i comandi di Dio, «possiamo» prendere parte, ogni domenica od ogni giorno, alla sua liturgia eucaristica, «possiamo» servire i nostri fratelli, che sono le sue membra. Il lettore nota che da un pezzo, e senza sottolinearlo, siamo entrati nella sfera della preghiera continua.
4. «Pregate di continuo»
Se, come tutte le cose, noi siamo creati «nel» Verbo, e perciò anche «per» il Verbo «in cui tutto ha la sua esistenza», se d’altra parte questo Verbo è diventato carne, natura, uomo come noi, allora noi ci realizziamo solo se, risvegliando nel nostro intimo più profondo questo «Verbo sostanziale», noi, nel Verbo, rispondiamo a Dio e al mondo. Ma poiché, come abbiamo visto, questo stesso Verbo non è stato generato da Dio eteronomamente in vista della creazione, bensì da sempre riposa nel seno del Padre e con lui in un comune spirito è un solo colloquio, il luogo della creazione e di noi stessi non può essere che all’interno di questo colloquio; per Lui noi siamo prescelti «prima della fondazione del mondo», creati per amor suo, redenti «nel suo sangue» e dotati del divino «Noi» dello spirito; non dobbiamo sforzarci di raggiungere questo luogo dall’esterno, noi vi siamo già insieme con tutto il mondo. E mentre realizziamo la Grazia dell’essere-nel-Verbo e, con questo, dell’essere-in-Dio, noi abbiamo la Parrhesia, l’accesso immediato, libero e filiale al Padre (l’esatto contrario del «castello» di Kafka), dobbiamo solo ricordarci in un attimo, in un passo, dove siamo in realtà per incontrare Dio che è in colloquio con noi, anzi nel cui colloquio noi ci troviamo. «Infatti Egli non è lontano da ognuno, da noi, in Lui viviamo, in Lui ci muoviamo, in Lui siamo» (At 17,7).
Stiamo attenti a questo «noi». Da soli, e presi individualmente, noi esistiamo solo come peccatori. Come graziati, come persone in colloquio con Dio siamo sempre in comunità. Ecco ancora una differenza sostanziale da tutte le tecniche orientali di preghiera. Sempre si parla di «Padre nostro», «mio» solo in quanto noi tutti siamo «uno solo» nel Figlio. La preghiera dice «nostro» sotto un doppio aspetto: il Padre è «nei cieli» e il cielo non è soltanto Lui nella sua comunione con il Figlio e con lo Spirito, bensì: «voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli … e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione» (Eb 12,22/23). Si consideri la curia coelestis dell’Apocalisse per rendersi conto di dove entriamo, quando diciamo «Padre nostro». In Dio noi troviamo il mondo, tanto quello prescelto, che quello in via di attuazione e quello compiuto. Per questo noi possiamo presentarci a Lui isolati dalla terra, noi siamo una parte di questa «festosa riunione» in atto e quindi portiamo costitutivamente con noi tutti coloro che sono in cammino con noi. Questa unione con tutti in Dio non significa affatto l’anonimità del singolo nella folla, infatti noi siamo «tutto» solo come «uno solo», il Verbo sommamente personale che rende tutti partecipi della propria unicità. Per questa ragione siamo istruiti a pregare non nella folla, ma in una «cameretta», cioè nel cuore, dove noi siamo e possiamo essere quell’Uno che Dio ha inteso e amato. Come Gesù era il solo davanti al Padre e tra gli uomini, così ogni uomo è solo, non solo nella nascita, nella morte e nel giudizio, ma anche per tutta la durata della sua vita tra gli uomini, per potersi presentare a Dio e agli uomini portando come dono la propria unicità. Di fronte a questa solitudine non bisogna fuggire nella socialità (come fanno oggi molti che non riescono più a pregare personalmente e ritengono che in mucchio sia più facile). Ma la «cameretta» del cuore è stata già da sempre aperta in Gesù, Egli è per l’eternità l’uomo dal cuore trafitto e svuotato. Se l’isolamento del cuore esiste già fisicamente, per pompare il sangue attraverso tutto l’apparato circolatorio e la comunità delle membra, allora il cuore di Cristo è espropriato in modo tale da far scorrere il suo sangue – «versato per voi e per molti» – soltanto come donato, attraverso l’organismo della chiesa. E questa chiesa, che è il suo corpo e la sua sposa, non potrebbe affatto corrispondere a questa ricezione se il suo cuore non fosse stato già da sempre trafitto sette volte «perché siano svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,35). Cristo e la chiesa, come «una cosa sola», sono in questo flusso comune il sacramento del mondo, che insegna alla sua infermità, attraverso il mistero della morte e resurrezione quotidiana, tanto il morire che il rivivere a Dio.
Pregare di continuo significa quindi soltanto realizzare ciò che significa il volgersi al mondo e a Dio. Naturalmente ciò richiede anche lo sforzo di rivolgersi a Dio espressamente, quotidianamente, coscientemente, disinteressatamente (non per la propria igiene spirituale) e rispettosamente, di ricordare e meditare le parole e le azioni di Cristo, in lode, ringraziamento e supplica. Senza una simile preghiera articolata non si giunge al «pregare in ogni tempo». Dobbiamo per questo darci del tempo per entrare davanti al Verbo e all’Immagine originaria, in modo che egli stesso abbia il tempo di imprimersi personalmente in noi. Così profondamente che più tardi noi ce ne ricordiamo nel movimento del mondo e lo vediamo risuonare e risplendere dovunque. Se ciò avviene nell’amore non c’è grande pericolo di dimenticarlo del tutto. L’amore di Cristo si mantiene come una nota puntata attraverso le scintillanti semicrome (come il fa e poi il do nella «Toccata» in fa di Bach); nota puntata dell’anamnesi, perché in tutto vi è l’eucaristia, la ricordante «lode della sua grazia» (Ef 1,6).
E questo, ancora una volta, non come tecnica o destrezza. Piuttosto nel senso della confessione di Paolo «noi nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare» (Rm 8,26). La capacità ci può talvolta essere donata, poi per lunghi tratti sentiamo il nostro dilettantismo e il nostro fallimento. Noi non troviamo nessuna via per incontrarlo e vorremmo, come Tommaso, toccare le ferite, mentre non eravamo presenti. «Ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili». Se noi fossimo convinti della nostra tecnica di concentrazione e di immersione ciò non accadrebbe. Ma poiché tutto è aperto e incompleto, la preghiera divina, «l’incenso della preghiera», che irrompe fino a Dio, può emergere attraverso i varchi dalle profondità più nascoste del nostro cuore. «Ma colui che scruta i cuori», Dio Padre, «sa che cosa desideri lo Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio» (Rm 8,27). Dio intercede per noi presso Dio. La preghiera continua è dunque, infine, un colloquio di Dio con Dio solo? No davvero. Il cuore del Figlio e quello della sua chiesa sono trafitti. Non in modo frammentario, ma totalmente. Ciò significa che il cuore che si è fatto uomo e il cuore umano si corrispondono totalmente. C’è nel mondo il perfetto «sì» «in sostituzione dell’intero genere umano», per tutte le sue situazioni (talvolta troppo) mondane, un sì intramondano, in cui l’intero sì di Dio al mondo si è fatto definitivamente carne e «Amen» (2 Cor 1,20). All’interno di questa preghiera perfetta e incessante è avvolta la nostra preghiera incompleta.
Lasciamo le ultime parole a Origene: «Prega senza interruzione colui che unisce il pregare con le sue opere quotidiane e con la preghiera le azioni che le si confanno, poiché anche le rette opere, l’attuazione del precetto appartengono all’ambito della preghiera. Poiché il precetto “pregate continuamente” può considerarsi attuabile solo quando noi concepiamo l’intera vita di colui che prega come una sola, grande e coerente preghiera. Una parte di questa grande orazione è anche ciò che abitualmente si chiama preghiera» (De Or. 12,2).
- Sheila Ostrander-Lynn Schroeder: Psi. Die wissenschaftliche Erforschung und praktische Nutzung übersinnlicher Kräfte des Geistes und der Seele im Ostblock. Scherzverlag 1974.↩
Hans Urs von Balthasar
Titre original
Vom immerwährenden Gebet
Obtenir
Thèmes
Fiche technique
Langue :
Italien
Langue d’origine :
AllemandMaison d’édition :
Saint John PublicationsTraducteur :
Paola ViottoAnnée :
2024Genre :
Article
Source
Strumento internazionale per un lavoro teologico Communio 20 (Milano, 1975), 28–35 [tr. riveduta per questa edizione elettronica]